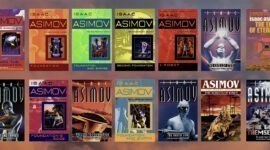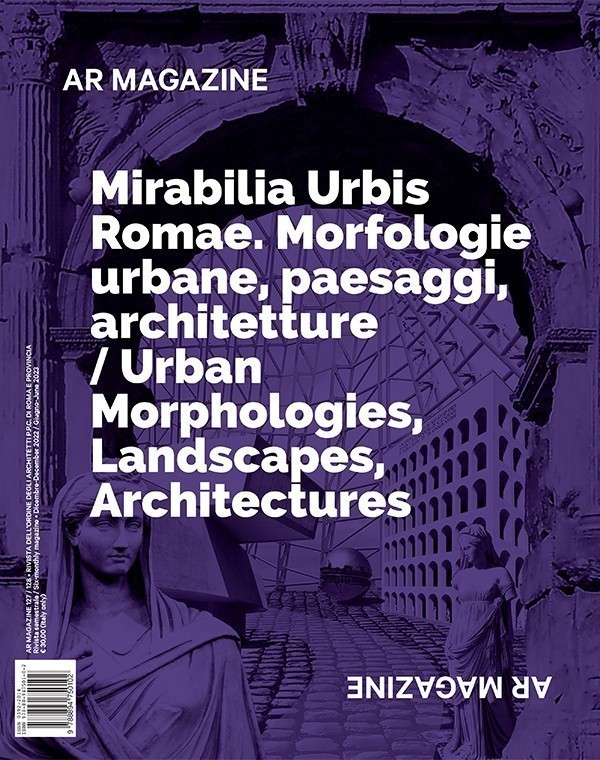Atti del Convegno “Abitare la Terra” – A cura di Daniela Gualdi e Flavio Trinca
Si ringraziano gli ospiti intervenuti per la preziosa partecipazione.
Si ringraziano Simona De Sanctis, Antonietta Salustri e Laura Tondi per il contributo alla trascrizione degli atti.
IV SESSIONE
Saluti Istituzionali
Luca Ribichini
La sessione mattutina si è conclusa con una bella immagine di Carlo Aymonino che inquadrava il Marco Aurelio: mi sembra una cosa molto importante, legata proprio alla occasione della giornata mondiale della terra. Il Marco Aurelio sta proprio sul mondo, questa era l’idea iniziale di Michelangelo, quindi questo passaggio di testimone mi pare veramente importante. Grazie davvero a Daniela Gualdi e a Flavio Trinca perché questa è un’occasione importante per parlare di noi, parlare del nostro ambiente, del luogo dove noi viviamo, in una giornata come questa, organizzata insieme ad altre manifestazioni a livello mondiale.
Credo che questo evento meriti grande attenzione: in un momento delicato e soprattutto di passaggio; la Casa dell’Architettura di Roma che è il luogo appropriato, per parlare di queste iniziative e oggi per parlare della Giornata Mondiale della Terra.
Penso che noi architetti siamo in qualche modo come casse di risonanza, tra quello che è l’ambiente e l’aspetto naturale. E qui entra un elemento di cui stamattina proprio Flavio parlava: il senso della Bellezza. Io sono convinto, e su questo credo di non dire cose sbagliate, che gli architetti, insieme ovviamente ad altre categorie professionali, siano in grado di declinare, ritrovare quel senso di bellezza. Diceva Sant’Agostino quando parlava del tempo: “se tu mi chiedi di spiegare il tempo non te lo so spiegare però in realtà lo conosco”; ebbene la bellezza è esattamente la stessa cosa, diventa complicato spiegarla, ma chi in qualche modo ha la capacità di declinarla sa come fare, e gli architetti hanno assolutamente questa capacità.
In chiusura vorrei ricordare un pensiero di Hölderlin che secondo me è perfettamente adeguato a questa giornata. Hölderlin dice che dobbiamo reimparare dalla natura, in modo tale da riguardare e di ricreare un nuovo rapporto con essa, quindi ricostruire sani e giusti principi. E in questo caso, poiché abbiamo una coscienza storica, passare da questa coscienza storica soprattutto per parlare delle finalità fondamentali quali ad esempio il senso della bellezza che è tipico dell’architettura come abbiamo detto prima. Tra i compiti fondamentali dell’Architettura c’è quello di migliorare la vita degli uomini: gli architetti in questo possono dire la loro e aiutarli ad abitare la terra in maniera poetica.
Io credo che sia importante ritrovare questo senso, insieme a tutta la parte tecnologica che sarà sicuramente importante, ma se non c’è questo afflato, questo spirito di essere umano e di anima rischiamo di perdere questa sfida.
Introduzione ai lavori
Flavio Trinca
Questa mattina è stata estremamente interessante, abbiamo toccato tanti argomenti, importanti non solo per la nostra professione, affrontati da tanti punti di vista differenti, con sensibilità diverse, con momenti estremamente poetici.
Apriamo la sessione pomeridiana dando spazio a dei nostri colleghi, architetti paesaggisti dell’AIAPP di cui anch’io sono socio, ricoprendo il ruolo pro-tempore di vice presidente della Sezione Lazio-Abruzzo-Molise-Sardegna, sezione che ha prodotto questo “Manifesto per la Ripartenza del Paesaggio”; documento elaborato durante il periodo del lockdown duro, appena iniziata la pandemia, che offre una serie di proposte e di risposte alle emergenze per poter affrontare il futuro in maniera differente.
Ringraziamo ancora i colleghi dell’AIAPP LAMS che hanno prodotto questo video molto bello, e per il manifesto che hanno promosso.
Proiezione del video AIAPP-LAMS “Manifesto per la Ripartenza del Paesaggio”
Daniela Gualdi
Buonasera a tutti. Presentiamo le ultime due sessioni di questo convegno che abbiamo intitolato, rispettivamente: “La grande Cecità, The Climate Change: verso la sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale”, “Vedere come una Città: il contributo dei progettisti al futuro della civiltà umana”.
Questo pomeriggio approfondiremo le tematiche della sostenibilità ambientale attraverso il confronto e il contributo del giornalismo scientifico, dell’architettura, della pianificazione urbana e paesaggistica per intravedere le prospettive future verso questa nuova sostenibilità complessivamente intesa da parte della Comunità dei progettisti.
Come sappiamo la Biennale di Architettura di Venezia curata da Hashim Sarkis ha come titolo “How we will live together” – come vivremo insieme; è una domanda che oggi va rivolta sia alla dimensione sociale e politica, quanto all’immaginazione degli spazi nei quali vivere insieme.
Vorrei quindi concludere con la speranza che l’accadimento epocale rappresentato dalla pandemia diventi il punto di partenza di una ricerca sulla realtà umana e l’abitare, che richiede la forza di un pensiero nuovo senza distanze e confini, richiede la necessità della Scienza, della Conoscenza e dell’Arte.
IV sessione: “La grande Cecità, The Climate Change: verso la sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale”
Introduzione alla quarta sessione
Daniela Gualdi: Introduciamo la quarta sessione con un breve filmato di Yasmeen Lari, prima donna architetto del Pakistan, che nel 2000 ha chiuso il suo studio di progettazione per dedicarsi all’Heritage Foundation of Pakistan, fondazione nata con lo scopo di salvaguardare il patrimonio culturale del paese.
Proiezione del video di Yasmeen Lari, Jane Drew Prize 2020
Credo che Yasmeen Lari non abbia bisogno di presentazioni. Il nostro è un omaggio al suo grandissimo lavoro e al suo straordinario coraggio per introdurre questa sessione di lavoro.
Vi presento molto velocemente i relatori di questa sessione, perché ciascuno di loro ha un curriculum importantissimo, piuttosto complesso da sintetizzare. Comincio col presentarvi Alessandra Viola, giornalista e scrittrice, conduttrice e produttrice televisiva, autrice di saggi di divulgazione scientifica tra cui “Flower power: le piante e i loro diritti”, “Trash: tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti”, “Verde brillante, intelligenza e sensibilità del mondo vegetale” con Stefano Mancuso. Ha un dottorato di ricerca in Scienza delle Comunicazioni e in Scienze Agrarie e Ambientali, collabora con il Center for the Humanities and Social Change alla Università Ca’ Foscari di Venezia. È autrice di trasmissioni scientifiche per la TV, scrive romanzi per ragazzi e dal 2001 dirige il centro di produzione L’arca d’arte. Chiederei ad Alessandra di cominciare questa sessione di lavoro e passerei poi la parola a Francesco Mancuso, Emilio Caravatti e Alfredo Brillembourg.
Alessandra Viola
Buonasera a tutti. Poiché stasera il tema è quello della cecità, io ho pensato di declinarlo, nei pochi minuti che abbiamo a disposizione, su tre punti. Quindi parlerò della cecità che abbiamo di fronte al mondo vegetale, della cecità nei confronti dei cambiamenti climatici e in ultimo della cecità che ci attanaglia per quanto riguarda la considerazione morale e diciamo il sistema giuridico iniquo che stiamo costruendo.
Partiamo quindi dalla Plant Blindness, che è che il termine inglese per definire la cecità che proviamo nei confronti del mondo vegetale. Questa iniziale intuizione è stata confermata anni fa da degli scienziati che hanno sottoposto a dei campioni di persone delle fotografie nelle quali venivano ritratte delle grandi macchie di vegetazione con degli animali all’interno e poi hanno chiesto alle persone di descrivere quello che vedevano, un po’ come ora potrebbe accadere se io vi chiedessi di dire che cosa vedete qui. Penso che molti di voi direbbero una donna, Alessandra Viola, una persona che parla, eccetera, e pochi sosterrebbero che ci sono, in realtà, una persona e una pianta.
Il punto è proprio questo: quando noi siamo portati a descrivere una scena che riguarda il mondo vegetale e anche un solo animale e ci viene chiesto cosa vediamo solitamente, siamo portati a dire che vediamo soltanto l’animale. È una cecità di tipo evolutivo perché le piante di fatto per noi non hanno mai rappresentato un problema ma sempre una risorsa, mentre gli animali in alcuni casi, soprattutto quelli feroci, naturalmente, sono stati anche dei nemici pericolosi dei quali era importante e opportuno accorgersi subito. Questa cecità vegetale, istintiva se volete, si è accompagnata poi ad una forma di cecità culturale che ci deriva, diciamo ci è percolata dentro, se volete attraverso tutta la cultura, la religione, soprattutto quelle occidentali.
Partiamo dalla Bibbia, all’interno della quale noi siamo, in qualità di specie umana, i dominatori di tutto il creato; l’uomo di fatto deve governare su quello che è stato creato da Dio, ma soltanto su quello a cui Dio ha infuso il soffio vitale, e le piante sono certamente ultime in questa scala.
Ancora nel Medioevo si usavano raffigurazioni in cui l’uomo era al vertice di una piramide di tutti i viventi e l’ultimo gradino era rappresentato proprio dai sassi, insomma dagli esseri inanimati, e solo in quello posto appena sopra erano situate le piante. Ecco, oggi noi sappiamo che le piante non rappresentano più questo ultimo gradino degli esseri viventi. Anzi, la ricerca scientifica ci dice molte cose diverse, più interessanti se volete, rispetto al mondo vegetale. Tuttavia questa nostra Plant Blindness, rimane purtroppo declinata in molti e variegati modi, un po’ per ignoranza, e un po’ perché, pur avendo a disposizione tutti i dati necessari, non siamo ancora riusciti a farci un’idea complessiva di che cosa sia questo regno vegetale, di cosa sia una pianta.
Non per dire che sia necessariamente facile, perché le piante non sono come gli animali, né tanto meno come gli esseri umani; a partire dal fatto, per esempio, che noi siamo degli individui, quindi degli esseri viventi che non si possono dividere etimologicamente, mentre le piante non sono degli individui ma degli esseri dividui, cioè che si possono dividere, come saprà chiunque ha tentato, per esempio, di riprodurre un geranio per talea, rompendone un pezzo e poi piantandolo nella terra. Ma non è solo questo. Le piante sono mediamente molto più longeve degli esseri umani, mi riferisco in particolare agli alberi, e alcune hanno delle strutture veramente impressionanti. Sono naturalmente molto più alti e hanno massa molto maggiore e, come dicevamo, possono essere molto molto più vecchi.
Alcune piante sono veramente sorprendenti, penso per esempio al Pando, che è un unico essere vivente vegetale ma alla nostra vista è un bosco di 43 ettari che si trova nello Utah.
Nessuno di noi entrando in questo bosco potrebbe sospettare di essere in presenza di un unico essere vivente vegetale. Sono tutte forme variegate di questa cecità vegetale che ci perseguita e che si estende anche, per esempio, ai mille modi in cui le piante si interfacciano con l’ambiente, nel linguaggio. L’idea che la pianta sia sensibile certamente non passa perché quando noi diciamo di qualcuno “poverino quello è un vegetale” o “è ridotto a un vegetale” parliamo di una vita menomata, depotenziata, alla quale manca senz’altro qualcosa. Invece, al contrario, alla pianta non manca assolutamente nulla, se non la capacità probabilmente di spostarsi dal luogo nel quale nasce, perché non possiamo neanche dire che non abbia la capacità di movimento, perché sappiamo invece che le piante si muovono eccome.
Le piante, al contrario, sono in una relazione fortissima con l’ambiente che le circonda, senz’altro più profonda di quella che abbiamo noi, per il motivo semplicissimo che hanno bisogno di mettersi in relazione con l’ambiente per la loro sopravvivenza.
Quindi la scienza ci dice oggi, che le piante possono comunicare tra loro e con gli animali, e probabilmente hanno comunicato, provano a comunicare anche con noi, influenzano alcune delle nostre scelte, ci sono delle teorie molto interessanti su questo argomento. Sappiamo che sono in grado di sentire l’ambiente con i loro sensi che sono i nostri 5 – la vista l’udito il tatto l’olfatto il gusto, adesso sarebbe troppo lungo addentrarci in ognuno di questi – e in più, con altri circa 15 sensi, che noi non abbiamo: le piante ad esempio sentono la gravità, sentono i campi elettromagnetici, sentono alcuni nutrienti nel terreno, cosa che noi, purtroppo, non riusciamo a fare. Quindi siamo senz’altro ciechi a non renderci conto di che straordinari esseri viventi siano.
Le piante sono degli essere viventi intelligenti, e lo sono se noi adottiamo, come è opportuno fare quando si parla di intelligenza, una definizione condivisa che, in questo caso, potrebbe essere la definizione di tipo evoluzionistico che l’intelligenza è una capacità connaturata alla vita e che è quella di saper risolvere i problemi. Ecco, nessun essere vivente stupido può sopravvivere sul pianeta, su un pianeta così complicato come il nostro. Dunque le piante sono intelligenti, comunicano, sentono l’ambiente, memorizzano, imparano, fanno delle cose veramente straordinarie. Eppure noi siamo ciechi. Questa è la prima forma gravissima di cecità. Anche perché le piante mettono a disposizione gratuitamente, una serie di quelli che, con orrenda definizione, chiamiamo servizi ecosistemici. Pensiamo ad esempio alle piante in città. Per esempio le piante ci puliscono l’aria dalle particelle sottili, dalle terribili PM10, oppure drenano l’acqua, quando piove in grande quantità, a patto che noi gli lasciamo un po’ di terra intorno alle radici per poterla risucchiare. Poi ci aiutano ospitando quel poco di fauna rimasta, aiutano a mitigare le zone troppo calde o troppo fredde sempre all’interno delle città, ci fanno ombra. Insomma servono veramente a tantissime cose a costo zero. Oltretutto producono ossigeno.
Degli esseri viventi così straordinari, dai quali noi traiamo la maggior parte dei nostri principi medici, curativi, moltissimi materiali da costruzione, moltissime cose che si possono mangiare, quindi cibo e molto molto altro; andrebbero senz’altro difesi con tutte le nostre forze. Invece, sappiamo che stiamo deforestando ad una velocità inverosimile, al punto che oggi, rispetto agli inizi del Novecento, siamo perfino riusciti ad avere sulla terra più materiali prodotti dall’uomo rispetto ai materiali, alla biomassa, prodotta dalle piante, che è un record assoluto, dal mio punto di vista totalmente negativo.
In 10.000 anni, cioè da quando abbiamo inventato l’agricoltura, siamo riusciti a dimezzare il numero di alberi piantati sul pianeta, e considerate che questa percentuale sta aumentando a dei ritmi vertiginosi. Abbiamo tagliato circa 3000 miliardi di alberi, ce ne erano circa 6000 miliardi sul pianeta. Adesso il problema è che, non possiamo davvero più far finta di nulla, il pianeta sta attraversando cambiamenti climatici rapidissimi e molto pericolosi.
Questi cambiamenti climatici, per i quali noi spendiamo convegni e grandi chiacchiere, probabilmente non riusciremo a fermarli ai ritmi attuali, potremo soltanto mitigarli e l’unica “tecnologia” della quale disponiamo per togliere dall’atmosfera l’anidride carbonica in eccesso, che noi emettiamo, sono gli alberi. Dunque ancora una volta, anziché deforestare, dovremmo piantarne molti di più. Ed è quello che stanno facendo molti Paesi aderendo ad una campagna che è stata lanciata dalle Nazioni Unite e si chiama One Trilion Trees per piantare entro circa due decadi un triliardo di alberi, quindi un terzo degli alberi che abbiamo tagliato fino ad oggi.
Forse questo potrebbe aiutarci, ma bisogna imparare a farlo bene e dunque anche a fare sopravvivere le piante dopo averle piantate che, paradossalmente, è un grosso problema. Anche in Italia ci sono alcune campagne, alcune personalità si sono spese per questo; oltre a mettere gli alberi sui grattacieli, potremmo metterli in tantissimi altri posti nelle nostre città; potremmo mettere piante sui tetti, dovremmo veramente mettere delle piante ovunque.
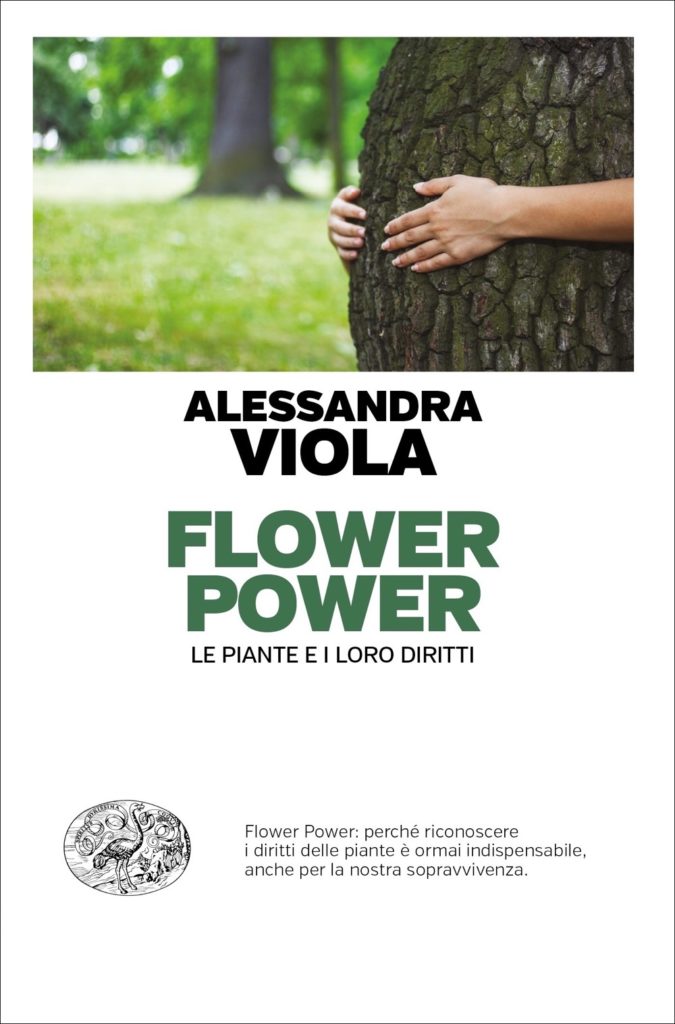
Quali sono i problemi che ci impediscono, e qui mi avvio alla terza cecità e alla conclusione, di renderci conto di quanto straordinarie siano le piante? Considerate che queste nostre coinquiline del pianeta Terra ci sono da molto molto più tempo di noi e ci rimarranno dopo che noi ci saremo estinti, cosa che se continuiamo in questo modo, probabilmente avverrà più rapidamente rispetto alla media degli altri esseri viventi; e questo nonostante la nostra presunta superiore intelligenza di specie.
Cosa ci impedisce di salvaguardare le piante? Io me lo sono chiesto a lungo dopo essermi occupata della loro intelligenza; il punto è che non ci siamo mai interrogati sulla possibilità che le piante abbiano dei diritti. Che cosa vuol dire questo? Che la considerazione morale che noi tributiamo a noi stessi in primis, quindi ai bambini, agli adulti, agli anziani, alle donne, ai neri, agli orientali, agli omosessuali e a tante altre categorie di persone, ci impone di comportarci nei confronti di queste categorie di persone o di esseri viventi tutelandoli, per esempio abbiamo già cominciato a interrogarci sui diritti degli animali.
Invece alle piante abbiamo semplicemente riservato una legislazione ambientale, dal mio punto di vista estremamente carente, forse non solo dal mio punto di vista, se qualcuno ha idea dello stato in cui versano gli ecosistemi terrestri.
Da circa 10-15 anni ci interroghiamo sulla possibilità che le piante abbiano effettivamente dei diritti. La prima è stata la Svizzera a chiederselo, però non siamo riusciti a dirimere la questione e abbiamo deciso tout court che, siccome non sappiamo dargli diritti, di conseguenza loro non ne possono averne.
Io ho studiato un po’ questo tema e ci ho scritto un libro che è la prima proposta al mondo per il riconoscimento dei diritti delle piante e mi sono convinta che non esiste un punto in cui, secondo le nostre attuali conoscenze scientifiche, filosofiche e giuridiche, si possa tracciare un confine tra chi deve avere dei diritti e chi non ne deve averne. Questa proposta si inserisce all’interno di una proposta più complessiva e di un movimento del diritto ambientale che è quello che sta riconoscendo i diritti di alcuni ecosistemi.
Sta accadendo molto rapidamente nel mondo: hanno iniziato la Bolivia e l’Ecuador, due paesi sudamericani che hanno inserito i diritti della madre terra nelle loro costituzioni, e da allora hanno anche consentito alle persone di difenderli. Hanno promulgato delle leggi per applicare questi principi costituzionali, addirittura si sono anche già celebrati i primi processi, per esempio contro l’inquinatore di un fiume in Ecuador, e la riparazione di questo danno per la prima volta non è andata a chi, essere umano, aveva avuto un danno da questo inquinamento, ma al fiume.
E da lì è stata una specie di valanga: sono stati riconosciuti i diritti del Gange in India, di alcuni ghiacciai, di un lago in Ohio, di boschi, foreste, perfino della prima specie vegetale. Insomma, la discussione è avviata. Io penso che sarebbe veramente tempo di cominciare a parlarne, se non addirittura di spingersi fin dove sono arrivata io, cioè scrivere una dichiarazione dei diritti delle piante. A cosa servirebbe riconoscere questi diritti?

Perché, in molti, quando ne parlo, dicono che forse basta potenziare la legislazione ambientale.
La mia risposta è che no, non è un caso che ogni volta che noi abbiamo combattuto una guerra, ogni volta che un soggetto è stato in grave sofferenza, come è stato il caso dei bambini dopo la prima guerra mondiale, dell’umanità intera dopo la seconda guerra mondiale, per le atrocità che erano state commesse, e delle donne dopo migliaia di anni di, non voglio dire, sfruttamento ma insomma di diverso trattamento, degli animali quando abbiamo scoperto gli orrori degli allevamenti intensivi, non è un caso che a tutti questi soggetti noi abbiamo riconosciuto dei diritti. E allora perché non alle piante? Perché continuiamo a considerare le piante come qualcosa di meno importante, come una vita diminuita, come una vita ha meno necessità di essere rispettata.
Per noi le piante sono delle risorse. Quando noi tagliamo un albero, tagliamo un bosco, diciamo che andiamo a fare legna, non diciamo che stiamo uccidendo un essere vivente. Questa prospettiva è quella che a mio avviso va assolutamente cambiata per poter entrare veramente in una nuova epoca, in una nuova era; dunque non ha nessun senso continuare a parlare di Green New Deal o riempirsi la bocca con grandi progetti fin quando non cominceremo a riconoscere le piante per quello che sono, cioè esseri viventi con i quali condividiamo il pianeta.
Per di più senza le piante la nostra sopravvivenza sarebbe assolutamente impossibile; andrebbe ricordato che se noi ci estinguessimo domani, alle piante non accadrebbe nulla; mentre se si estinguessero le piante noi in breve moriremmo. È un rapporto di forza che tendiamo spesso a dimenticare e sottovalutare e che invece sarebbe bene tenere sempre a mente.
Daniela Gualdi: Grazie Alessandra, spero che riuscirai a trattenerti ancora un po’ con noi così da avere un breve confronto fra voi alla fine.
Passiamo direttamente a Francesco Musco; dal mondo ambientale e delle piante di cui ci ha brillantemente raccontato Alessandra Viola, passiamo a parlare della pianificazione urbanistica in Italia, cioè di punte emergenti in questo momento nel nostro paese, che sono poco conosciute per chi non è del mestiere e di cui Francesco Musco ci parlerà.
Francesco Musco è architetto e urbanista docente di Pianificazione Urbanistica al Dipartimento di Cultura del Progetto dell’Università IUAV di Venezia. Dirige il corso di laurea in pianificazione e politiche per la città il territorio e l’ambiente, ed è componente del Consorzio per il Coordinamento delle Ricerche sul Sistema Lagunare di Venezia e nel 2011 ha fondato il Planning and Climate Change Lab attivo nella ricerca applicata a supporto delle innovazioni per la pianificazione e la progettazione per la città resiliente.
Francesco Musco
Grazie a tutti, grazie di questo invito. Occuparsi di urbanista e pianificazione in un’ottica di ridisegno delle nostre città anche rispetto allo scenario che cambia, ormai in maniera molto rapida, ben è stato introdotto da Alessandra Viola poc’anzi, ma il tema di ridisegnare le città è un tema di cui si dibatte da un po’ di tempo. Disegnare le città soprattutto in un’ottica di scenario climatico che cambia e che ormai da una ventina d’anni ha incrementato in maniera sempre più rilevante eventi meteo-climatici estremi sulle nostre città. C’è una grande divisione tra le città e gli organismi internazionali di decisione pubblica, soprattutto in quello che è sempre stato forse uno degli elementi che ha reso più complicato scendere di scala, rispetto al ridisegno della città in un’ottica di scenario climatico che cambia.
Occorre capire e comprendere che le città sono di fatto un laboratorio, dove l’impatto del cambiamento climatico maggiormente incide, e quindi anche nell’ottica di quella cecità che ci illustrava Alessandra poc’anzi; si tratta soprattutto di capire di come ridisegnare la città partendo dal basso. Il rapporto tra città e adattamento climatico è un tema di cui si parla in maniera esplicita da almeno una quindicina di anni. Nel 2011 quando abbiamo fondato il Planning and Climate Change Lab presso lo IUAV di Venezia, di fatto il tema era considerato abbastanza lontano da ciò di cui debbono occuparsi gli urbanisti o gli architetti. È un tema da sempre molto complicato da porre e introdurre nel modo di pensare, organizzare, gestire la nostra città; soprattutto per il fatto che il tema del cambiamento climatico è sempre stato gestito a una dimensione internazionale, o meglio globale. Globale è una dimensione che però in una prima fase ha tenuto le città lontane dal dibattito. Ed è per questo perché le città sono il luogo dove le maggiori estraneità ambientali si generano, perché è nell’ambito dell’ambiente costruito che tutto questo avviene: le estraneità clima-alteranti vengono generate e, contemporaneamente le città diventano anche il laboratorio dove sperimentare soluzione per l’adattamento.

Slide dalla presentazione del progetto SECAP presentato alla Casa dell’Architettura in occasione dell’evento Abitare la Terra – Info sul sito: https://www.citiesunderpressure.eu/it/home-italiano/
Le sperimentazioni delle soluzioni per l’adattamento rappresentano un viaggio ancora lungo da compiere: le grandi città del mondo si stanno attrezzando – da New York a Londra, a Parigi, a Barcellona – se pensiamo anche ai così detti Piani di Adattamento anche sviluppati in una logica di apertura del dibattito.
Ma il tema rilevante della questione è quello di riuscire ad arrivare anche alle città piccole. Arrivare alle città piccole perché occorre estendere in una dimensione strategica il ruolo delle città e il ruolo che può essere dell’urbanistica, soprattutto in una dimensione minore. Il tema fondamentale è quindi quello delle vulnerabilità all’interno delle città, e come queste possano essere il più possibile pensate in una certa dimensione.
Progettare l’adattamento delle nostre città significa soprattutto scendere di scala, dai grandi indirizzi dati dagli organismi internazionali – pensiamo in particolar modo a International Planner for Climate Change, che a livello globale da anni si sta impegnando nella definizione di soluzioni e di indirizzi sullo scenario climatico globale in cambiamento. Il tema fondamentale è capire cosa agisce, cosa succede anche sulla scala locale. Occorre quindi capire, da un lato, la sensibilità delle nostre città dal punto di vista degli impatti potenziali attesi, dall’altro quale è la capacità adattiva in una certa prospettiva delle nostre città e; capire in che modo sia possibile incrementare questa capacità adattiva per ridurre di fatto la vulnerabilità connessiva.
La capacità adattiva dipende anche dalle cose che sentivamo poco fa: la progettazione delle strutture verdi, le progettazioni delle reti blu, che diventano elementi fondamentali per cercare di comprendere in che modo le nostre città possono essere calmierate rispetto ad uno scenario climatico in rapido cambiamento. Quali sono le città italiane che di fatto stanno sperimentando, parlando soprattutto di città piccole?
In questi ultimi anni, quando il laboratorio Planning Climate Change è diventato una struttura molto ampia che ospita più di 20 ricercatori che si occupano da varie prospettive di comprendere in che modo sia possibile riprogettare le nostre città o inserire all’interno di quelli che chiamano gli strumenti urbanistici, una dimensione di adattamento perché di fatto sono strumenti di cui tutte le città in qualche maniera sono dotate.
L’obiettivo è soprattutto quello di capire in che modo sia possibile intervenire esattamente dove sono maggiormente attesi gli impatti del cambiamento globale e nella loro scala locale. Molte città medie stanno sperimentando – ci sono molte sperimentazioni in città medie come Mantova e Padova. In altre città italiane come a Bologna a Reggio Emilia, hanno avviato dei processi di integrazione nei loro strumenti urbanistici di quella che può essere considerata la dimensione fondamentale dell’adattamento al cambiamento climatico.
Quindi cosa occorre fare? Occorre soprattutto di cambiare visione.
Esiste il tema dei diversi linguaggi anche tra le varie discipline che si occupano delle città: penso al rapporto che ci può essere tra chi si occupa di cambiamento globale, cambiamento del clima e chi si occupa di progettazione e pianificazione urbanistica. Bisogna capire in che modo le nuove tecnologie ci possono aiutare. Occorre capire anche in che modo gli impatti attesi sulla scala globale hanno degli effetti molto diversi sulle scale delle nostre città, anche a distanze non molto ampie, anche all’interno dello stesso continente o dello stesso paese. Se parliamo ad esempio di città costiere il tema diventa assolutamente più rilevante. Recentemente le Nazioni Unite, hanno proposto l’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, che contiene già un’agenda di temi che possono guidarci all’interno della declinazione dell’adattamento sulla scala locale delle nostre città. Fornendo qualche linea di indirizzo operativa: c’è un tema di progettazione alla microscala, il tema del verde, dell’infrastruttura verde è un tema fondamentale; usare il verde in una dimensione di infrastruttura capace di calmierare quelli che sono due dei principali impatti che avvengono quando si parla di città: l’acqua ed il calore in eccesso.
Il sistema del verde, come il sistema delle infrastrutture blu, di tutte le infrastrutture grigie che fanno parte di tutti i sistemi tecnologici, che in qualche modo possono venirci in aiuto nelle città, sono almeno tre degli elementi che fanno da base al ragionamento che ci serve per ridisegnare l’ambito urbano anche in una ottica di adattamento. Dobbiamo imparare a compensare le scale della progettazione: c’è un tema di area vasta, molti degli impatti che avvengono sulle nostre città sono generati in bacini territoriali molto più ampi, pensiamo a tutti i fenomeni alluvionali, pensiamo ai fenomeni di calore urbano o di generazione di isole di calore urbano.

Dobbiamo riuscire ad immaginare queste tematiche in una visione integrata di pianificazione urbanistica, e non come singoli aspetti da risolvere in maniera singolare, ma in un’ottica di piano. L’Italia è fatta di piccoli centri e quindi non possiamo lasciare la dimensione della resilienza solo alle grandi città; c’è un tema anche di esportare e diffondere esperienze nuove e buone pratiche che permettano l’incremento della capacità dei nostri piani urbanistici di contribuire alla dimensione dell’adattamento. Io credo che dalle sperimentazioni in corso in Italia, in Europa e nel resto del mondo. molto si possa prendere e molto si possa esportare in termini di buone esperienze e buone pratiche; tutto questo va però integrato in una dimensione di innovazione e miglioramento degli strumenti di disegno, progettazione e di pianificazione delle nostre città.
Daniela Gualdi: Ringrazio Francesco Musco per averci proposto strategie di resilienza, in Italia e in Europa, anche a favore della salvaguardia del nostro patrimonio architettonico. Io spero che Venezia fra 100 anni non sia sott’acqua come qualcuno prevede.
Parleremo adesso di alcuni interessanti interventi che ci portano in zone del mondo particolarmente difficili, che partono da situazioni complesse. Noi abbiamo alle spalle una storia ricca, c’è chi questa storia purtroppo ce l’ha già drammaticamente fragile e quindi introdurrei Emilio Caravatti, progettista italiano dello Studio Caravatti_Caravatti Architetti – con Matteo Caravatti Chiara Gugliotta e Elena Verri; le loro tematiche coniugano attività professionale e impegno sociale e si traducono in esperienze di progettazione prevalentemente in ambiti di marginalità.
Le opere dello studio hanno ottenuto significativi riconoscimenti come il Premio Architetto Italiano 2017. Emilio Caravatti è stato inoltre visiting professor di teoria e critica dell’architettura presso l’Ecole Polytechnique Federale di Losanna.
Emilio Caravatti
Grazie dell’invito e per l’organizzazione di questa giornata, che colgo soprattutto come un’occasione di confronto necessario tra formazione, personalità e professionalità molto diverse, un confronto che io ritengo in questo momento debba far lievitare i temi e soprattutto il dibattito tra di noi, questa è sostanzialmente la logica con la quale ho accolto questo vostro invito.
Condivido con voi lo schermo, perché parlerò su una serie di immagini che in qualche modo parlano del nostro lavoro. Cerco qui il senso di una nostra presenza oggi, che è nel testimoniare un’esperienza di piccola scala come è quella del nostro studio, che in realtà è un gruppo di lavoro familiare, tra fratelli e compagni di vita; uno studio artigianale che svolge attività e progetti legati ad un impegno che potrei definire sociale; partendo però da una considerazione molto basica, forse banale ma necessaria: ognuno di noi prima ancora di essere un architetto o un progettista, è sicuramente un cittadino. E quindi dentro il contesto ampio della discussione come quello che ho sentito stamattina inserisco una interpretazione un po’ più minuta, un po’ più pratica, evidenziandone le premesse che la connotano, più che gli aspetti formali e costruttivi che lascerei in un secondo piano. Sullo sfondo di immagini legate ai nostri lavori, utilizzerò e descriverò delle parole chiave che per noi sono da tempo determinanti e sulle quali si orienta o cerca di orientarsi il nostro operare professionale e non solo.
Prendo spunto dal riferimento al titolo che avete dato al tavolo e uso questa immagine, magari banale ma emblematica della grande cecità di cui si parla. È una grande cecità leggibile a diversi livelli. Io qui la utilizzo come specchio della mia professione che è semplicemente quella di fare l’architetto. La grande cecità è fissata in queste immagini, nella cristallizzazione di uno status quo generale, che concentra l’attenzione sulla brillantezza di alcune parti del pianeta, dove solo ciò che appare esiste, e proprio per quello è presente; e questa è un po’ la regola della società dello spettacolo. Uno status quo che si concentra quasi esclusivamente sull’accecante porzione luminosa che in qualche modo esclude nell’invisibilità del buio l’attenzione verso la percentuale maggioritaria, anche solo geograficamente, di un tutto.
La grande cecità si concentra sugli effetti abbaglianti e indebolisce e in qualche modo quasi annulla la capacità di lavorare sulle cause e sui bisogni più profondi. Perde in qualche modo la realtà delle cose e produce un’eccezionalità che è funzionale agli effetti abbaglianti, intendendo con il termine di eccezionale proprio gli atti di esclusione. Etimologicamente parlando eccezionale vuol dire proprio l’atto di escludere qualcosa.
La grande cecità ha precise collocazioni geografiche e corrisponde nel nostro campo professionale ai ben noti riflettori del panorama e del palcoscenico internazionale dell’ architettura. Nell’estrema semplificazione, anche un po’ primitiva, che ho adottato in questa presentazione, questo scenario dualistico pone un’apparente contrapposizione che pone sulla professione o sull’agire di ognuno un bivio fondamentale riguardante il nostro ruolo.

Qual è il nostro ruolo in realtà? E dove ciascuno di noi orienta la propria pratica?
Per stabilirlo io credo che abbiamo l’obbligo di interrogarci sulle finalità e gli obiettivi che portiamo avanti quotidianamente. Questa è la necessità della scelta di un punto di vista per meglio orientarci verso il soggetto della nostra osservazione o della nostra azione. Serve uno sguardo sempre rivolto, per quanto possibile, alla stessa domanda che è di base, che è questa: costruire che cosa?
È una domanda che coinvolge l’identità stessa dell’architetto, definito come avete fatto nell’abstract del convegno, prefiguratore di spazi. Io alleggerirei un po’ questa definizione in un più pragmatico costruttore di luoghi, con la necessità del supporto e dell’indicazione di altre figure, che per preparazione e competenza prefigurano gli spazi del domani. Noi, io credo, almeno personalmente, che ne siamo poco in grado.
C’è un’affermazione che ho trovato fondamentale per chiarire a cosa possa portare questa domanda, questo costruire che cosa, nel nostro essere cittadini e anche architetti, cioè che la politica inevitabilmente determina i luoghi, e lo è qualsiasi spazio che trasformiamo in un luogo.
Ma se è vero che la politica determina i luoghi, è altrettanto vero per noi progettisti che la loro costruzione rappresenta inevitabilmente un atto politico. È una frase che porta a delle conseguenze molto pesanti, se è ascoltata e in qualche modo messa in pratica, traducendola appunto in una pratica, i segni che tracciamo, sono il risultato di una volontà, e gli spazi in cui viviamo sono la forma esplicita di una politica.
Stamattina Amos Gitai ci ha parlato di un architettura come gesto politico trasposto in elementi materiali, così ha detto. Mi ritrovo moltissimo in questa definizione. Infatti sono una serie di decisioni di un progetto a determinare il cambiamento e la trasformazione da uno spazio in un luogo.
Questo vale ancora di più per gli interventi minimali, di piccolissima scala.
Una mostra a Francoforte a cui partecipammo anni fa, annunciava nel titolo “Small scale big change”, che proprio nella piccola scala risiede la possibilità di grandi cambiamenti.
Noi frequentiamo e viviamo all’interno di luoghi spesso pensati senza un’attenzione critica verso chi li abiterà o li vivrà e ogni volta che interveniamo sulla trasformazione di uno spazio ci confrontiamo sulle finalità in quanto ne siamo in qualche misura i depositari e al tempo stesso costruiamo ogni momento, a piccole dosi, la nostra eredità. Questo è ciò che fa della nostra azione, un’azione politica. Questo vale ancora di più per chi cerca di praticare con difficoltà, mille dubbi e nessuna certezza, come il sottoscritto, una professione basata sulla costruzione dei luoghi; questa relazione tra politica e luoghi esige delle scelte, determina la presa di una posizione, un prendere parte che persegua un’idea di trasformazione e di cambiamento tra la luce abbagliante e l’intenso buio.

Con il nostro piccolissimo studio cerchiamo dei percorsi per praticare architettura anche immergendoci nel buio della scena. Sono delle immersioni che ci riportano a degli scenari inaspettati, che rendono più evidenti alcuni fondamentali di base che connotano il nostro fare. Nella ricerca orientata al mondo buio si ha la sensazione di potersi riavvicinare al grado zero della pratica, riscoprendo strumenti primitivi e imprescindibili.
Da tantissimi anni, da quando ho scattato questa immagine, forse una quindicina, mi porto dietro questa foto, di una persona che si chiama Baccarì Balè, che è uno scavatore di pozzi nella Savana del Sahel, e che meglio di altre, secondo me, rappresenta il grado zero dell’architettura. In questa immagine infatti ritroviamo i tre elementi essenziali del nostro bagaglio strumentale: il materiale, il sistema e il linguaggio. Il vuoto come massima espressione materica è un buco, un buco nel terreno, un buco profondo. Dall’altra parte la scelta di un sistema costruttivo appropriato, il corpo umano di Baccarì Balè che come una macchina a disposizione ruota a 360 gradi alla ricerca di qualche cosa sotto terra penetrando nel terreno e dall’altra parte linguaggio di un’astratta purezza, di una forma geometrica che è il cerchio, rappresentato proprio da questa rotazione di un corpo. È una sintesi, di ciò che dovrebbe essere un’architettura, uno strumento al servizio di una comunità. Questa immersione nel buio ci conduce in spazi inaspettati in quanto ricerca, geograficamente però spesso questi spazi sono anche molto prossimi a noi, non è necessario viaggiare a chilometri di distanza per poterli incontrare: è un buio che rispetto ai canoni di un immobile status, nel venire in superficie dal grado zero disvela le sue potenzialità.
Qui ad esempio nelle carceri dove possiamo animare degli spazi, costruire dei luoghi di relazione dove mettere in comunicazione la qualità di esperti committenti quali potrebbero essere in potenza e sono le persone detenute che lì dentro vivono, con potenziali futuri progettisti quali per esempio gli studenti universitari. Sono attività che richiedono certamente continuità e soprattutto permanenza per poter cogliere le opportunità di progetto e di trasformazione; ad esempio anche nelle scuole con i bambini o nelle case di riposo con gli anziani. Sono tantissimi gli spazi di ombra dove poter trasmettere e parlare con linguaggi comprensibili di architettura, luoghi dove organizzare e diffondere attività educative; dunque l’architettura come una disciplina che possa comprendere non il solo fatto fisico del costruire ma anche azioni capaci di produrre nel tempo soprattutto occasioni di conoscenza, di scoperta e di apprendimento.
C’è un connubio indissolubile che collega al concetto di architettura gli esempi mostrati; è una parola sempre più abusata negli ultimi anni; molto utilizzata ma troppo spesso solamente ripetuta come tale e che insieme ad architettura costituisce un inseparabile binomio. La parola è comunità. Architettura e comunità è un binomio sul valore, dipende dagli obiettivi che cerchiamo e dal senso che attribuiamo alla nostra azione di scegliere verso quale comunità orientare l’architettura che produciamo. Benché legata a tantissimi vincoli, la nostra professione ha delle possibilità di scelta e questa è una delle scelte di cui fa parte, assolutamente libera per ciascuno di noi.
Credo che anche questo sia un prendere parte, e che sia la costruzione di un’infrastruttura piccolissima come la scuola comunitaria in un villaggio della savana del Burkina Faso o del Mali o una piazza nel centro storico di una città piuttosto che un museo di una nota industria di produzione delle macchine del gelato nella Pianura Padana, fare architettura non può prescindere dalla comunità dentro la quale la stessa si colloca.
Nell’acquistare il valore di servizio, non si può fare a meno della comunità e nell’essere elemento costituente di una comunità risulta fondamentale avere chiara, da parte nostra, la consapevolezza di essere noi, come progettisti, solamente un semplice segmento su una retta; una retta lungo la quale i progetti potranno prendere strade condizionate sì dalle nostre scelte, che altrettanto però potranno essere autonomi e indipendenti nel loro svilupparsi prima e soprattutto dopo la realizzazione; cioè molto meno espressione individuale e molto più strumento collettivo di trasformazione, che tenda ad innescare dei processi e costruire spazi di relazione e di contatto.
È una collocazione che ci porta lontano dall’eccezionalità delle cose alla quale accennavo prima, una consapevolezza che ci allontana, per fortuna, dal pretenzioso binomio edificio-oggetto di abbagliante luminosità. Ogni architettura è un progetto inserito in un processo, è una ovvietà che però è utile ripetere per l’importanza che riveste per la nostra professione. È un atto capace di determinare delle conseguenze significative, un processo dentro al quale ciascuno di noi può scegliere il gradiente di implicazione, a seconda delle conseguenze che si decide di determinare sulla comunità ma anche soprattutto su noi stessi. Un edificio-processo costruisce gradi di opportunità. Fuori da una retorica partecipativa o partecipativistica, l’architettura produce scelte che regalano gradi di libertà per la comunità che vi partecipa.
La domanda che spesso ci facciamo, che traduce nella pratica più quotidiana il costruire che cosa, a cui facevo riferimento è molto semplice: alla fine che cosa regala un edificio?
La domanda che mi pongo ogni volta che in qualche modo prendo una matita in mano e cerco di pensare a cosa possa essere.
La risposta io credo si nasconda dietro un investimento soprattutto di livello personale di ciascuno di noi, una risposta che diventa uno strumento per misurare l’efficacia o meglio il rapporto più appropriato tra un’architettura e la sua comunità. È la scelta di una distanza o di una possibilità, è un parametro che incide sulla qualità di un’architettura.
Quanta più distanza o quanta più prossimità riusciamo ad instaurare con la comunità che si sceglie, o che con la comunità che ci sceglie, tanto più saremo in grado di aggiungere un ulteriore metro di valore al nostro lavoro.
È la scelta che ci aiuta a valutare quale misura scegliere nei confronti delle cose, tra distanza e prossimità. È la scelta determinante della scala della nostra implicazione, alla fine. Tra continuità e permanenza nelle cose si sintetizza a mio parere in quattro livelli, una piccola scala di valori che ho cercato per darmi uno schema utile. I livelli che passano dallo scoprire un’attenzione, il primo livello un’attenzione per qualche cosa, ad approfondire questa attenzione trasformandola in un interesse che può arrivare fino a prendersene cura e ad un ultimo livello fino addirittura potersi, volersi caricare di una responsabilità. Evidentemente spetta a noi, a ciascuno di noi, scegliere gli strumenti più adeguati ma soprattutto sceglierne il peso che vogliamo sostenere, è una scelta in questo senso certamente politica.

Chiudo con le immagini di una piccola storia personale nell’ambito di un lavoro di circa 10 anni fa, forse poco più. La persona che si vede si chiama Pierre Umibalì. Pierre prima di diventare un muratore costruttore di volte nubiane in terra cruda di edifici in mezzo alla Savana, era un coltivatore agricolo di miglio e di mais nella Repubblica del Mali in un piccolo villaggio. Senza avere la possibilità di andare a scuola, senza quindi sapere né leggere né scrivere; dopo poco più di un mese di cantiere per la costruzione della scuola in un villaggio a 10 km dal suo, sul retro di un pacchetto di sigarette, a seguito di una telefonata che ci scambiammo, Pierre disegnò esattamente la pianta della scuola che insieme stavamo costruendo nel cantiere.
Tornato in Italia qualche tempo dopo trovai questa perfetta corrispondenza tra la scuola di Fansiracorò su Google Earth e davanti a queste due immagini io credo che ognuno di noi ha la possibilità di scegliere la distanza da tenere tra questo pacchetto di sigarette fisico o virtuale che sia, e l’immagine della scuola visibile con un click da un computer, come potrei fare in questo momento da Monza, da un telefono a Roma o da qualsiasi luogo nel quale voi vi troviate. Questa cosa si sintetizza con le parole di Hassan Fathy, che anche Yasmeen Lari cita, e che ho sempre trovato illuminanti; meglio di chiunque altro ha saputo descrivere il senso di quanto oggi vi ho voluto proporvi in questi pochi minuti.
Hassan Fathy dice che se vogliamo un fiore non cerchiamo di farlo con carta e colla, ma dedichiamo fatica e intelligenza a preparare il terreno per poi piantare il seme e lasciarlo crescere. Allo stesso modo se vogliamo sfruttare il desiderio che ha il contadino di costruire, dobbiamo darci da fare per preparare il terreno creando un’atmosfera, un clima sociale nel quale la costruzione possa sbocciare; non dobbiamo sprecare energia e costruire edifici che per quanto raffinati e degni di nota rischiano di essere sterili come dei fiori artificiali. Grazie.
Daniela Gualdi: grazie a te Emilio, innanzitutto per la tua lezione di grandissima civiltà, quello che ci hai mostrato mi ha toccato profondamente, perché tutti oggi parliamo di sostenibilità, soprattutto noi architetti. Comprendo il forte legame anche con il filmato iniziale con cui abbiamo introdotto la sessione, della grande scelta di una donna importante come Yasmeen Lari che diceva appunto che bisogna togliersi le scarpe e camminare a piedi nudi sul terreno per sentire la terra, e da lì iniziare a pensare cos’è sostenibile. Di questo ti ringrazio veramente, perché le immagini che ci hai mostrato mi fanno pensare che c’è tanto lavoro da fare nel mondo.
E sulla scia di quello che tu ci hai mostrato, presento Alfredo Brillembourg che nel 1998 fonda con Hubert Klumpner gli Urban-Think Tank a Caracas, Venezuela, uno studio di design interdisciplinare, che offre soluzioni e pratiche innovative lavorando in contesti di marginalità, avvalendosi delle competenze di diverse professionalità. A partire dal 2007 entrambi insegnano alla Columbia University, dove fondano il Sustainable Living Urban Model Laboratory (S.L.U.M. Lab) e dal 2010 sono titolari di una cattedra di Architettura e Progettazione Urbana al Politecnico Federale di Zurigo (ETH). Si dedicano alla formazione di una nuova generazione di professionisti in grado di trasformare le città del XXI secolo, evidentemente nelle aree povere del mondo.
Proiettiamo due brevi loro filmati.
Proiezione di Vertical Gym e Empower Shack Housing South Africa.
Alfredo Brillembourg
Jasmine Lari ed Emilio Caravatti hanno in parte introdotto quello che è il lavoro al quale mi dedico e molte delle idee che sono state espresse mi trovano pienamente d’accordo. L’idea che l’architettura e l’urbanistica siano due aspetti separati tra di loro è una strada, un percorso, non più rinviabile. La metropoli del XXI secolo rompe questa logica architettonica che vede appunto la forma urbana contrapporsi all’infrastruttura e ai mutamenti ecologici. Ora siamo consapevoli del fatto che a causa dello sviluppo di città in tutto il mondo e in particolar modo in Sudamerica, che è una realtà che conosco molto bene, anche in India, le persone stanno creando sempre più infrastrutture che dividono le città, che le frammentano; questo che sto mostrando è un diagramma molto chiaro realizzato nel 1955 e che mostra una frammentazione urbana, una sorta apartheid urbana. Da un certo punto di vista il Sudafrica ha usato un po’ questo sistema per dar vita alla frammentazione interna e lo stesso vale anche nel caso delle linee ferroviarie e delle mura che vengono utilizzate all’interno delle città, pensiamo per esempio ad Israele e alla Palestina. Quindi come riusciamo ad unire assieme la componente naturale ed ecologica creando uno spazio che sia in grado di combinare il tessuto cittadino con l’ambiente naturale?
In questo momento stiamo lavorando molto in Colombia ed in Sudafrica, in particolare quest’anno, e abbiamo pubblicato un nuovo libro che si chiama “L’architettura e la città”, che in realtà richiama un libro di Aldo Rossi. In questo caso noi parliamo dell’architetto come della persona che è responsabile nel creare cambiamenti all’interno della città. Quindi noi non parliamo dell’architettura in questo volume bensì della figura dell’architetto.
Oggi è la Giornata Mondiale della Terra, quindi dobbiamo guardare alla situazione globale. Abbiamo cercato di produrre dei saperi e delle conoscenze da diffondere in tutto il mondo. Io sono nato a New York, ma la mia famiglia ha origini venezuelane e insieme al mio partner stiamo viaggiando in tutto il mondo e guardiamo la realtà delle diverse città. Quindi l’idea è, come possiamo e dobbiamo fare per sposare insieme diversi concept dell’abitare? Pensiamo a come rendere più informali le città formali dell’Ovest e formalizzare le città informali di altre parti del mondo. In questo momento stiamo lavorando esattamente a questo, stiamo pensando a come rompere questa divisione politica che soprattutto tende a dividere il mondo in Nord e Sud, anche in Est e Ovest se volete. In che modo possiamo prendere ciò che voi vedete disegnato in rosso, cioè l’informalità che è presente in tutto il mondo e redistribuirla in maniera che il panorama sia più coerente.

Questa è la pianta di Caracas che dimostra che il 60% di Caracas è una realtà informale, è caratterizzata da insediamenti informali, la parte in giallo per l’appunto. Non dovremmo pensare a questi luoghi come delle realtà divise dal resto della città; dobbiamo invece elaborare delle strategie che ci permettano di raccordare queste realtà molto diverse della città.
Vedete nella foto come a destra ci sia una parte informale e a sinistra la parte formale, in realtà completamente distinte tra di loro. Questa è una situazione tipica in cui abbiamo una infrastruttura, in questo caso una superstrada, che ha creato una divisione netta all’interno della città, dando vita a due contesti assolutamente diversi. Ci chiediamo perché avvenga una cosa del genere, questa è politica, politica congelata, è una decisione governativa che ha espropriato il terreno e che ha fatto sì che avvenisse tutto questo.
Vediamo come anche a Mumbai e in molti altri luoghi della terra si crei questa divisione; una parte della proprietà viene invasa e occupata; dall’altra parte invece c’è uno sfruttamento da parte dei costruttori e se guardiamo a Caracas questo è quello che succede, come questi insediamenti informali si insinuano nelle valli tra le montagne; è importante rimuovere queste disuguaglianze, dobbiamo cercare di creare uniformità tra questa parte della città e la parte invece più formale; quello che facciamo nel mio studio è cercare di creare democrazia, sono 20 anni che stiamo cercando di promuovere una rivoluzione perché siamo convinti che l’architettura può dare vita ad una rivoluzione, ed è esattamente quello che stiamo cercando di fare. Noi abbiamo gli slums più densi al mondo nella nostra città, anche in Brasile abbiamo un milione di case costruite dagli stessi cittadini, è una Babilonia, è una scena incredibile inimmaginabile se non si va a vedere.

Tuttavia noi riusciamo a vedere qualcosa di positivo, qualcosa di interessante che ha a che vedere con la creazione di città come luoghi condivisi, un po’ come diceva Emilio, noi cerchiamo di addentrarci in queste città, nel loro aspetto informale, magari grazie alla baby-sitter che mi ha cresciuto che mi ha permesso di conoscere altre persone che vivono in questi ambienti e quindi mano a mano noi ci siamo addentrati in questa realtà e sono proprio le persone che abitano questi luoghi i partner fondamentali del nostro progetto. Ad esempio abbiamo fatto sì che una ONG organizzasse dei campionati di basket attraverso i nostri interventi. È quindi molto chiaro che la città rappresenta un mix molto complesso tra economia, società, politica e ambiente, ma ha a che vedere soprattutto con le persone e quindi se vogliamo fare la differenza dobbiamo avvicinarci alle persone; abbiamo il diritto di andare nelle città, abbiamo il diritto di avere delle infrastrutture, abbiamo il diritto alla casa.
Noi cittadini abbiamo diritto a tutto ciò, e l’architettura, questo è ciò che vogliamo affermare e rivendicare, può portare nuovamente a questi processi; può permettere a tutti i cittadini di avere delle abitazioni che siano sicure. Dobbiamo comprendere cosa vogliamo, dobbiamo comprendere dove agire e con chi. Non sto dicendo che l’Italia non ha già molti problemi, sicuramente avrà molti problemi anche questi problemi devono essere affrontati nello stesso modo, tuttavia quello che voglio dire è che in questo momento tutti i paesi più sviluppati in Europa devono trovare una strategia di carattere globale e non confinata solamente all’Europa.
Alla Biennale di Venezia abbiamo ricevuto un premio molto importante, tuttavia le nostre lotte vanno avanti perché il nostro lavoro non può limitarsi a questo, noi vogliamo continuare a lavorare sulle città che attualmente non sono altro che una suddivisione di lotti di terra individuali che crea separazione, città che non sono quello che per noi dovrebbero essere.
Neanche questa è la città, neanche quella che vedete nell’immagine nella parte sinistra, perché anche in questa immagine di sinistra ci sono molte carenze, tuttavia ha molto più a che vedere con il senso di creazione di una comunità. Dobbiamo pensare al paesaggio e all’architettura, al ruolo che l’architettura può giocare, come possiamo creare una società che sia coesiva?
Alcuni di voi sapranno che abbiamo iniziato a lavorare con delle funivie, abbiamo creato delle funivie, dando il via ad una situazione che ha permesso per l’appunto sviluppare un’infrastruttura dei trasporti. Attraverso la funivia che abbiamo creato la popolazione ha cominciato a potersi muovere in questo luogo che vedete, abbiamo raccolto 35 mila firme che hanno fatto sì che il governo cambiasse idea riguardo al progetto che volevamo proporre. Questa è la prima funivia, che crea un giro con 5 stazioni, un percorso totale di 2,5 km. Non è un processo di gentrificazione, abbiamo impiegato 10 anni affinché venisse approvato questo progetto, ma è un esempio unico del modo in cui si può ripensare il sistema urbano, in modo tale da poter volare sopra la città, fluttuare sulla città per meglio collegarla. Quindi abbiamo aggiunto un’infrastruttura nuova in una città preesistente che toccasse sia la città informale che la parte formale e abbiamo anche creato delle palestre verticali e queste sono alcune delle immagini che mostrano ciò che abbiamo fatto attraverso l’aiuto delle persone, attraverso gli artisti locali. Le persone impiegavano 2 ore per percorrere questo tragitto ora impiegano 10 minuti, ora le famiglie possono andare in ospedale, possono essere curate e possono andare dai propri dottori.
Era qualcosa di inimmaginabile fino a poco tempo fa, quindi questo progetto ha trasformato totalmente la vita delle persone. Se iniziamo a pensare a questa città divisa in tematiche; pensiamo allo sport, all’istruzione, all’infrastruttura per i bambini, pensiamo alla mobilità, ai trasporti. Tutte queste come aree tematiche della città, il cibo, l’igiene, la sanità. Partiamo dallo sport. Queste città informali ubicate ovunque nel mondo, India, Asia, Africa, in queste città non ci sono sufficienti infrastrutture dedicate allo sport.
Quest’uomo noi lo chiamavamo 7 perché era tifoso di una squadra e portava sempre una maglietta con il numero 7 e grazie anche al suo aiuto abbiamo creato una struttura come quella che vedete, di 4000 metri quadrati, composta di 4 diversi piani, nella quale vengono praticate diverse attività sportive. Un miliardo di dollari per creare una struttura di 4 piani, c’era solo un campo da calcio lì e da lì attraverso questa struttura verticale abbiamo creato un centro sportivo, in realtà abbiamo creato 5 strutture sia nella parte formale che in quella informale della città per unire le persone, per cancellare la realtà degli slums, per andare oltre. Questa è l’idea che si basa sulla creazione di centri comunitari nelle zone informali che permettono alle persone di vivere assieme, per strappare queste persone al mondo della droga.

Ora vorrei mostrarvi un’ultima immagine per concludere la mia presentazione. Se non comprendiamo il fatto che il futuro del XXI secolo va di pari passo con il cambiamento climatico, se non comprendiamo che l’architettura sociale e l’impatto dell’architettura sociale è ciò che dobbiamo fare e ciò di cui dobbiamo parlare, allora ci sarà una rivoluzione. Il Venezuela sta vivendo una rivoluzione da ormai venti anni; quando io ho lasciato il Venezuela un dollaro valeva 10 Bolivar, ora vale 2500 Bolivar, una svalutazione incredibile.
Ci sono delle lotte e proteste continue; lo stesso avviene anche in Africa nel Sudamerica, avviene in moltissimi luoghi della terra. L’Europa e il Nord America non saranno in grado di rappresentare delle isole, delle eccezioni; è importante che le nazioni si uniscano e uniscano i propri sforzi per dar vita ad un piano di azione molto forte e solido per cambiare veramente il mondo.
Daniela Gualdi: Io non posso che ringraziare, anche per questo meraviglioso intervento, Alfredo Brillembourg; è una lezione di vita la tua presentazione, il tuo lavoro. Non posso fare altro che ringraziarvi perché devo passare la parola alla tavola successiva, ma vorrei salutarvi dicendo che sono orgogliosa del vostro contributo come relatori; perché credo fortemente che l’architettura e la pianificazione debbano tornare a parlare al sociale ed occuparsi degli esseri umani e soprattutto delle aree più svantaggiate del mondo, altrimenti non avrà più senso continuare a fare convegni sulla sostenibilità.
Dunque vi ringrazio perché il vostro contributo conferma quello che anche gli artisti e gli studiosi che vi hanno preceduto questa mattina ci hanno ricordato, citando anche il pensiero di Gramsci. Bisogna tornare a fare una ricerca sulla realtà umana, economica, sociale e politica per poter perseguire e raggiungere l’obiettivo della vera sostenibilità. Questo credo sia il contributo oggi noi da Roma, possiamo offrire alla Giornata Mondiale della Terra.
Flavio Trinca: Grazie per il contributo che avete dato alla nostra giornata e soprattutto per avermi risollevato rispetto alla situazione attuale di professionisti, di ricercatori, di pensatori, di architetti. Mi fa piacere sapere che esiste ancora un’attenzione, un afflato etico, politico nel nostro fare.
Ho trovato molto interessante anche l’intervento di Alessandra Viola, che ci ha fatto capire che non solo dobbiamo guardare all’ambiente, al paesaggio e al territorio, in maniera multidisciplinare; sarà fondamentale avere “occhi diversi”, dobbiamo imparare a vedere anche con gli occhi delle piante.

_________________________________
_________________________________
Visual Editing:
Giuseppe Felici, Redazione AR Web
– Nell’immagine di copertina: Cueva de las Manos (Caverna delle Mani), Perito Moreno, Argentina