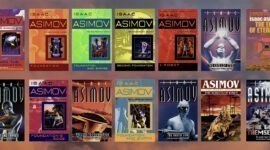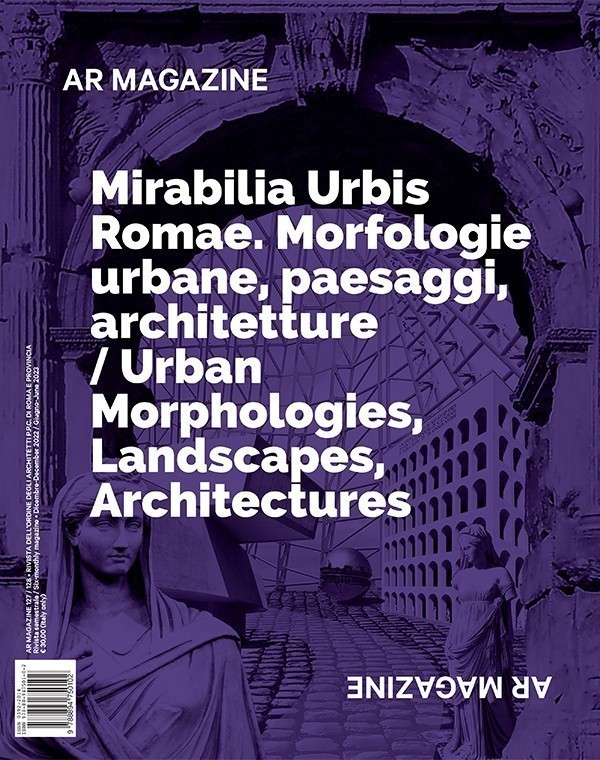Due giganteschi pericoli incombevano sulla Biennale Architettura di Venezia appena inaugurata.
Sui generis, suo malgrado, posticipata di un anno a causa della pandemia, la 17. Mostra Internazionale di Architettura correva molti rischi. Da un lato, c’era il rischio che l’emergenza sanitaria mondiale l’avesse influenzata a tal punto da doversi imbattere in una Biennale a tema COVID. Dall’altro lato, il rischio che non facendosi influenzare dalle circostanze, risultasse una mostra fuori luogo e disallineata con il contesto.
Entrambe le eventualità erano probabili e non facili da schivare. Con piacevole sorpresa invece questa Biennale Architettura 2021 dribbla le due ipotesi e ne esce vincente.
Il tema How will we live together? proposto dal curatore Hashim Sarkis, per poco o per nulla condizionato dall’emergenza e rimasto sostanzialmente invariato, regge all’impensabile circostanza che l’ha travolto e risulta attuale.
Addirittura più attuale di quanto sarebbe stato un anno e mezzo fa.
Il superamento di questa prova dimostra quanto la domanda fosse ben posta, proprio perché affondava su questioni ovviamente preesistenti che si sono rivelate, inasprite e aggravate, in tutta la loro drammatica evidenza nelle circostanze odierne.

“L’attuale pandemia globale ha indubbiamente reso la domanda posta da questa Biennale Architettura ancora più rilevante e appropriata, seppure in qualche modo ironica, visto l’isolamento imposto. Può essere una coincidenza che il tema sia stato proposto pochi mesi prima della pandemia. Tuttavia, molte delle ragioni che inizialmente ci hanno indotto a porre questa domanda – l’intensificarsi della crisi climatica, i massicci spostamenti di popolazione, le instabilità politiche in tutto il mondo e le crescenti disuguaglianze razziali, sociali ed economiche, tra le altre – ci hanno portato a questa pandemia e sono diventate ancora più rilevanti”. Queste le parole del curatore.
Il tema-quesito avanzato da Hashim Sarkis presuppone l’attribuzione all’architettura di una grande responsabilità (forse la più grande): infatti lega implicitamente a doppio filo la responsabilità del progetto della configurazione spaziale alla potenzialità della trasformazione sociale e politica.
“Il contratto spaziale anticipa, prova, articola, materializza, invariabilmente abilita o resiste, ma spesso sostituisce il contratto sociale” dichiara Sarkis.
Se dunque al contratto spaziale è conferita questa responsabilità, primario sarà chiedersi quale è il contratto sociale cui si aspira. Ed è qui che si spalancano, finalmente, le porte di una Biennale intersezionale in cui si sottolineano le relazioni inevitabili tra la disuguaglianza sociale, le discriminazioni di genere, di razza, di specie, di religione, le crisi ambientali, economiche e migratorie.
Tra le corderie dell’Arsenale e il Padiglione Centrale dei Giardini si inanellano così le risposte dei 112 partecipanti chiamati dal curatore (per la prima volta con una maggiore rappresentanza da: Africa, America Latina e Asia, con uguale rappresentanza di uomini e donne).
Cinque sono le sezioni che corrispondono ad altrettante scale di attuazione.

Nella prima, Among Diverse Beings, si riflette sulla necessità di progettare alla luce dei cambiamenti della concezione dei corpi umani e con una rinnovata empatia per gli altri esseri. Tra le opere, l’installazione “Your Restroom is a Battleground” (Matilde Cassani, Ignacio G. Galán, Ivan L. Munuera, Joel Sanders) riflette perspicacemente sul ruolo, tutt’altro che neutro, dei servizi igienici come spazi di dibattito e di battaglia delle lotte sociali, dalla ordinaria divisione binaria donne/uomini in poi. “Variations on a Bird Cage” (Studio Ossidana) esplora gli oggetti attraverso cui gli esseri umani formalizzano il loro incontro con gli uccelli, ripensando l’archetipo della gabbia e trasformandolo da strumento di reclusione a oggetto di meditazione, in una installazione decisamente riuscita.
La seconda sezione As New Households centra invece l’attenzione sulle tipologie residenziali e in generale sull’abitare collettivo, più rispondenti ai cambiamenti delle composizioni e dei nuclei sociali e familiari. Le opere variano da proposte che esaltano l’immutabile e atemporale, come “Ground” (Aires Mateus) che dichiara il suolo e il cielo come elementi di condivisione eterna, fino a quelle che ricorrono invece all’avanguardia biotecnologica, come “BIT.BIO.BOT” (ecoLogicStudio) che propone una sperimentazione 1:1 sulla rimetabolizzazione degli agenti inquinanti grazie al cianobatterio Spiriluna.

As Emerging Communities, la terza sezione fa appello al senso civico dell’abitare in comunità e sulle attrezzature sociali che possono conformarne nuovi modi di convivenza. Tra le opere spicca “Hacking (the resort): Water Territories and Imaginaries” (Storia Na Lugar) che inaspettatamente esplora la tipologia del resort all-inclusive, condensato di disuguaglianza per eccellenza, come possibilità; l’installazione, coraggiosamente composta di bottiglie di PET riciclato, traspone nel movimento dell’acqua la danza coreografica tra turismo e forza lavoro. Su comunità extra-umane particolarmente incisiva, sia concettualmente che nella resa fisica ed estetica, “Entangled Kingdoms” (doxiadis +) in cui diversi funghi – raccolti originariamente a Venezia, coltivati ad Atene e poi esposti nuovamente in una piastra di Petri – compongono un affascinante giardino che rende visibile ciò che esisteva già, ma che non appariva.
Across Borders, una delle due sezioni al Padiglione Centrale, ragiona sul superamento dei limiti e dei loro effetti sulla società e ambiente: i confini tra città globali e hinterland, i confini politici, i confini immaginari dei grandi patrimoni naturali. Tanto dure quanto necessarie le installazioni “Stateless Heritage: Dheisheh Refugee Camp World Heritage Nomination” (DAAR Decolonizing Architecture Art Residency), che indaga la condizione di rifugiato superando l’umanitarismo, ed “Aesthetic Borders Of Violence and (in)Visibility at Sea” (Forensic Oceanography), che, tra difficoltà di narrare e necessità di guardare, mostra la violenza nelle frontiere marittime delle acque mediterranee.
“Antarctic Resolution” (Giulia Foscari / UNLESS con Arcangelo Sassolino) è forse l’installazione più potente: un quanto mai inquietante fragore, prodotto dal movimento di un parallelepipedo metallico, ricorda in maniera eludibile lo scioglimento dei ghiacci, e accompagna l’accurata ricerca sull’Antartide che, lungi dall’essere un paesaggio naturale incontaminato, è (e lo sarà sempre più) una miniera di valori preziosa e contesissima.
Quinta e ultima sezione, As One Planet, allarga ulteriormente lo sguardo cercando di immaginare e anticipare il futuro del pianeta e spingendosi addirittura allo Spazio. “The Earth is an Architecture” (TVK), in un seducente e colorato plastico, considera lo strato del suolo della Terra, nei suoi quindici chilometri di spessore, come una complessa unica architettura in cui le trasformazioni umane costituiscono solo una, sebbene la maggiore, delle numerose forze che contribuiscono alla sua metamorfosi, equiparando centri abitati a catene montuose, infrastrutture a valli, manufatti a rocce. Con “Satellights: Orbiting the Thin Layer of Human Life” (Angelo Bucci) giungono le provocazioni acute di oltrepassare lo strato sottile di crosta terrestre abitabile e di installare sorgenti di luce artificiali nella Fascia di Clarke, in grado di illuminare intere città.

Infine, nel mezzanino del Padiglione Centrale, trova spazio “Future Assembly” (Studio Other Spaces).
Si tratta di un’esposizione caleidoscopica di cinquanta ‘stakeholders’ sovrumani, finalmente chiamati a far parte di una immaginifica assemblea chiamata a decidere le sorti del pianeta da un punto di vista che trascende l’umano. Partecipano funghi, gas, minerali, pipistrelli, alghe e molti altri esseri – viventi e non – tradizionalmente e a torto esclusi da scelte e legislazioni, finora sempre e solo antropocentriche. Un’opera collettiva plurale, aperta, sagace e pure bella, che da sola vale il viaggio.
“Un contratto spaziale potrebbe costituire un contratto sociale. Cerchiamo un contratto spaziale che sia al tempo stesso universale e inclusivo, un contratto allargato affinché i popoli e le specie coesistano e prosperino nella loro pluralità.”
Queste le intenzioni, attese, nell’intervento del curatore.
“Per essere un singolo devi essere una moltitudine“, ricordando le parole di Donna Haraway. Ecco quindi che acquista davvero un senso e un valore l’insieme eterogeneo e multiforme delle opere raccolte tra le Corderie e il Padiglione Centrale dei Giardini, che come miglior risultato ha probabilmente quello di mettere in discussione la centralità di chi le osserva.
Federica Andreoni
Redazione AR Web
Fotografie di Federica Andreoni